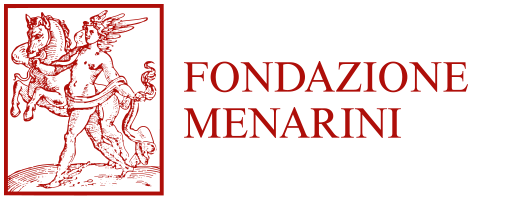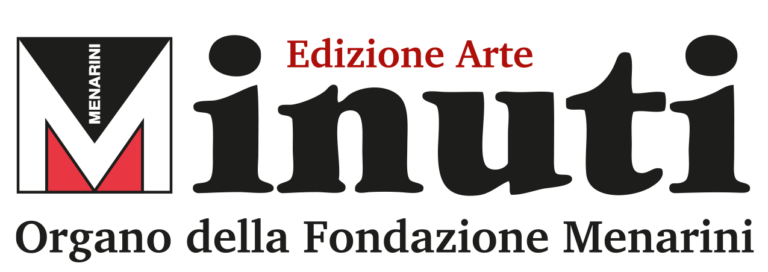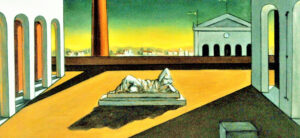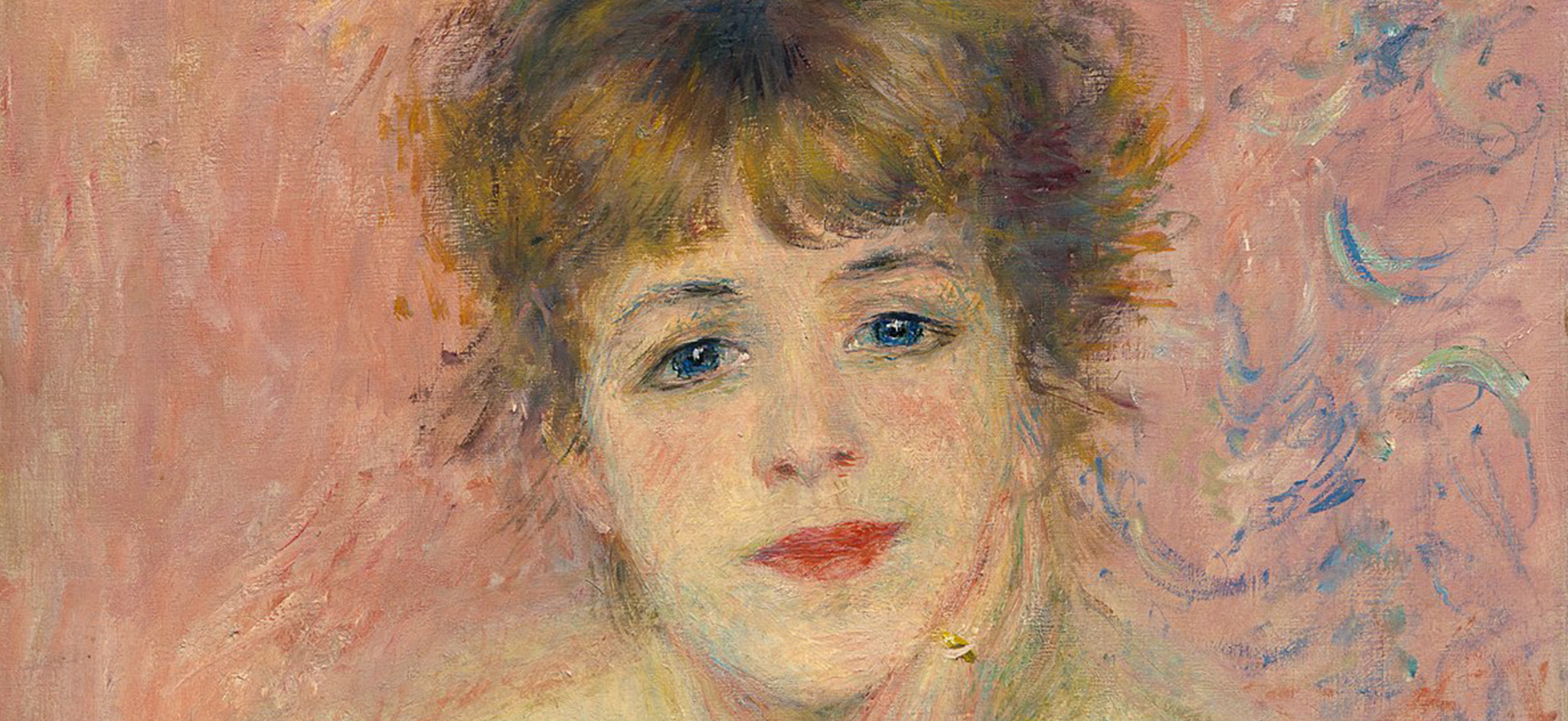
Renoir: sotto la luce italiana
di Francesca Bardi • Marzo 2023
Il pittore francese, considerato uno tra i massimi esponenti dell’Impressionismo, troverà in Italia la luce che temeva di avere smarrita
Contenuti speciali
Scopri di più su
fondazione